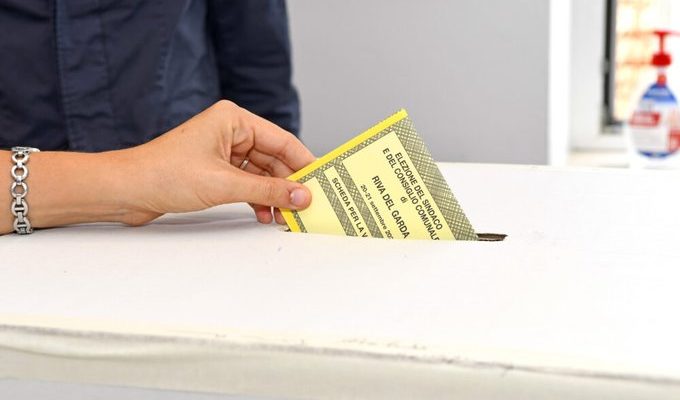
A ben guardare i risultati elettorali del voto dell’ 8 e 9 giugno, oltre ai ballottaggi che hanno avuto luogo qualche giorno fa, emerge in modo semplice un dato, non sempre preso nella giusta considerazione: l’astensionismo è il vero vincitore dell’ ultima consultazione. Un italiano su due non è andato a votare. E questo fatto è molto grave, perché mette in evidenza che con la disaffezione dei cittadini sta venendo meno un ruolo, quello dei partiti, che invece i Padri Costituenti avevano considerato molto importante, fondamentale per garantire la partecipazione dei cittadini alla vita politica nazionale. Ai partiti infatti la Costituzione assegna il ruolo di organismo intermedio in grado di creare il collegamento tra componenti della comunità ed i suoi vertici istituzionali .
Il punto di partenza della considerazione appena enunciata è l’articolo 49, che recita “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Questo testo nella sostanza, dopo aver affermato il diritto del cittadino alla libera partecipazione alla vita dei partiti, riconosce a questi ultimi il ruolo di organizzarli per individuare gli obiettivi da raggiungere a livello nazionale.
I partiti dunque in base alla costituzione si vedono assegnato il compito di coinvolgere i cittadini per farli riflettere e per definire le proposte relative alle scelte politiche generali. Da questa impostazione si ricava che ai partiti è dunque riconosciuta la titolarità di organismi intermedi con una finalità molto precisa, quella di coinvolgere i cittadini, di contribuire alla loro formazione sociale e di essere momento di sintesi delle varie istanze sociali. In base a questa funzione costituzionale ai partiti tocca pertanto il compito di aiutare i cittadini ad essere autentici protagonisti del loro destino e soprattutto tocca la missione di guidarli nelle scelte per costruire il destino della comunità.
Nell’immediato periodo dopo l’entrata in vigore della Costituzione i partiti hanno colto fino in fondo il significato e la portata dell’art. 49. Condizionati in termini positivi dal clima generale conseguente alla lotta di Liberazione e dal nuovo spirito costruttivo portato avanti da coloro che avevano contribuito alla caduta del Fascismo, spirito costruttivo che invitava alla partecipazione, i partiti si sono impegnati per favorire un ruolo consapevole dei cittadini nella vita e sviluppo dello stato. Molte infatti sono le iniziative culturali e formative impostate da questi organismi intermedi, resi nobili da un preciso dettame costituzionale.
Nelle loro sezioni, presenti in modo capillare in quasi tutti i comuni italiani, si organizzavano dibattiti, incontri culturali, settimane sociali per approfondire le tematiche politiche e preparare così una nuova classe dirigente. C’era anche qualcosa in più. I partiti spesso erano pure affiancati in questo lavoro da associazioni che si proponevano come compito non solo quello di fiancheggiarli nella raccolta del consenso, ma di contribuire agli approfondimenti sociali specifici degli iscritti, affrontando tematiche di riferimento ai settori nei quali le associazioni stesse si trovavano inserite.
Penso in questo caso ad esempio alle Acli, che puntavano alla formazione sociale cristiana dei lavoratori o a quelle organizzazioni, che si collegavano ai partiti per coincidenze ideologiche. In questo periodo anche i sindacati della classe lavoratrice, affiancando i partiti, contribuivano alla formazione politica dei loro iscritti. Storicamente parlando – perché anche questa considerazione riguarda un passato che ora non c’è più – sono pure da ricordare a questo proposito le scuole di partito, create in quegli anni appositamente per preparare coloro, che sarebbero stati chiamati a vario titolo a ricoprire incarichi pubblici a tutti i livelli, dal ruolo di consigliere di quartiere e comunale a quello di deputato.
I percorsi formativi in quegli anni erano obbligatori, così come indispensabile il rispetto del cursus honorum: si incominciava dalla carica di consigliere di quartiere o comunale per acquisire il diritto di accedere a ruoli più importanti. Oggi invece non è più così. Si accede, magari senza una preparazione di base, ai livelli più alti e più delicati dell’impegno politico, spesso con le conseguenze negative che sono sotto gli occhi di tutti.

Di fronte al grave fenomeno dell’astensionismo, che non solo dimostra una negativa disaffezione al voto e soprattutto sfiducia dei cittadini nei confronti della classe politica, ma produce un grave indebolimento della Costituzione, è necessario riprendere l’attività didattica di educazione alla cittadinanza e rimettere anche in piedi le scuole di preparazione politica. Innanzi tutto l’attività didattica di educazione alla cittadinanza.
Questo significa che la scuola deve aiutare a far capire l’importanza del voto e quindi della partecipazione del cittadino a questo importante momento della vita democratica di una comunità. Troppo poco a mio avviso viene fatto delle strutture scolastiche.
Devono inoltre essere riattivate le scuole di preparazione politica. Non si tratta, ma in questo caso è una sottolineatura ovvia, di riprendere i corsi di un tempo, si devono introdurre mezzi nuovi, strumenti attuali e, in particolare, si deve puntare ad un’educazione politica, che sappia affrontare tematiche che sono di grande interesse per l’uomo di oggi, per il cittadino che deve affrontare le difficoltà di un mondo che è in continuo cambiamento.
L’astensionismo è un fenomeno grave, che deve preoccupare tutti, compresi e cattolici e le loro organizzazioni. Ritengo infatti – e porto qui considerazioni che sono collegabili ad un mondo che mi appartiene e conosco abbastanza bene – che oggi sia dovere da parte dei Cattolici contribuire a rinforzare la democrazia, che certamente può essere consolidata anche con la partecipazione dei cittadini alle votazioni.
Devono essere impostati programmi formativi, che comprendano anche approfondite riflessioni sul significato del voto, sul valore del voto. Questo ovviamente non significa un ritorno al collateralismo, comporta invece offrire i mezzi che permettano alle persone di capire e quindi liberamente scegliere. In questo contesto poi vedo molto importante il ruolo che possono avere le organizzazioni cattoliche.
Mi vengono in mente organismi come le ACLI ( Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) o l’ MCL (Movimento Cristiani Lavoratori) che possono fare formazione anche civica. Sarebbe per questi organismi un ritorno alle origini, ma nello stesso tempo un contributo a salvare la democrazia partecipata in Italia.
Prof. Franco Peretti
Docente di diritto delle istituzioni europee